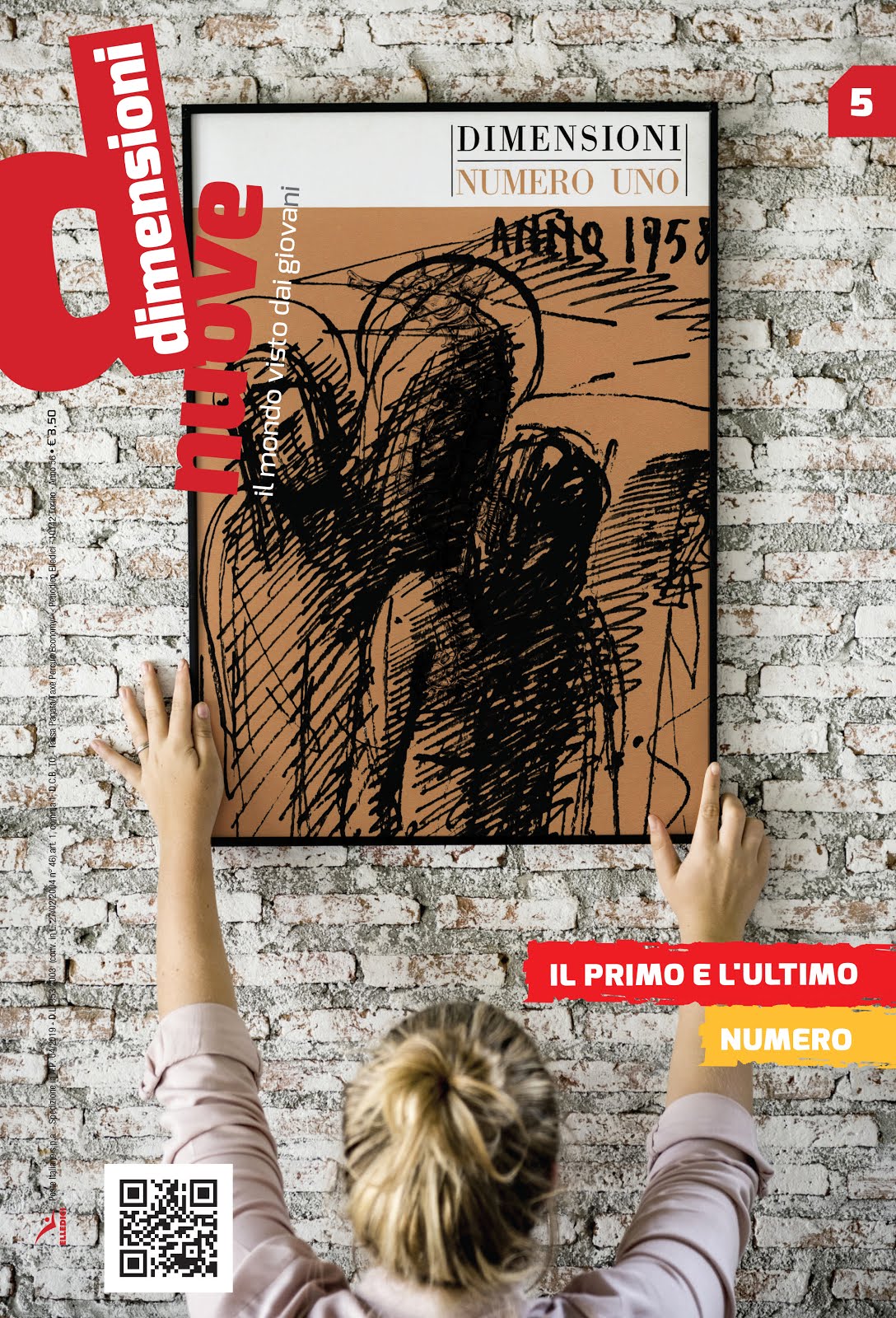Una magica bacchetta
di Ilaria Beretta Susanna Mälkki, la prima donna a dirigere alla Scala Una magica bacchetta Angelica e soave nei modi ma determinat...
https://www.dimensioni.org/2014/11/una-magica-bacchetta.html
di
Ilaria Beretta
Susanna Mälkki, la prima donna a
dirigere alla Scala
Angelica e soave nei modi ma
determinata come una valchiria,
ha saputo rompere i tabù del mondo
della musica classica
molto conservatore e maschilista ed
aprire strade nuove.
Una donna in cima alla Scala, ma stavolta solo per “spolverare” via
vecchi pregiudizi... Tocca a Susanna Mälkki, che da sola bacchetta più o
meno cento uomini, ma resta la signora di sempre. Caschetto biondo ramato,
frangetta sfilata e vispi occhi chiari, sul divanetto di un hotel cinque stelle
in centro a Milano la sua figurina esile stona un po’. Perché lei, una delle
poche direttrici d’orchestra d’un certo livello, parla in una tonalità per
niente retorica. Tanto che quasi non ci si crede che fra qualche ora
calcherà il podio della Scala.
Dalla sua Finlandia a Parigi, prima
donna alla guida del francesissimo Ensemble InterContemporain. Almeno fino
all’anno scorso, quando come direttrice è diventata l’ospite principale della
portoghese Gulbenkian Orchestra. Da Lisbona però vola dappertutto con la sua
inseparabile bacchetta magica.
Maestra Mälkki, quando ha
deciso di diventare direttrice d’orchestra?
In realtà non l’ho mai deciso. Certo, fin
da piccolissima mi sono interessata alla musica, tanto che iniziai presto a
suonare in orchestra. Poi, una volta ho provato a dirigere un piccolo gruppo e
ho sentito subito che il podio era il mio posto. Mi ci volle un po’ di tempo però,
prima che quell’impulso diventasse realtà, anche perché tutte le tradizioni
erano contro di me: se fossi stata un uomo avrei iniziato prima. Non decisi
tanto di fare la direttrice, quanto d’imparare a dirigere. E così, lavorando
sodo, sono arrivata qui.
Vent’anni fa lei ha lasciato
il posto di violoncellista in nome di questo sogno. Una scelta rischiosa...
Quando lasciai il mio lavoro, molti mi
diedero della pazza: in realtà io come violoncellista avevo un’abilità che
nessuno poteva togliermi, anche se stavo per fare dell’altro. Certo, anche
allora sapevo l’importanza di un buon impiego, ma ci ho provato lo stesso. Gli
altri erano scettici, ma per me se un sogno è un sogno, bisogna fidarsi di se
stessi e andare fino in fondo. Ovviamente nella vita capitano cose diverse, ma
in generale non si dovrebbe mai far tacere la propria passione.
 Lei è una
dei massimi esperti di musica contemporanea, sinfonica e operistica. Cosa ci
trova di tanto bello?
Lei è una
dei massimi esperti di musica contemporanea, sinfonica e operistica. Cosa ci
trova di tanto bello?
La musica contemporanea è legatissima alla
vita vera e perciò impone di scoprirla nella realtà. Per esempio, non la si può
capire restando davanti a un computer. Bisogna andare a cercare le note del
nostro tempo. E che lo si voglia o no, il suono del mondo odierno è molto
astratto. Una volta era diverso: in un museo si vedevano quadri bellissimi di
paesaggi ed era tutto lì. Oggi questo non basta, viviamo in una società che ci
manda impulsi tutti nuovi. Perciò la musica contemporanea è molto variegata, a
volte è radicalmente provocatoria e per questo piacerebbe ai giovani. Altre
volte si fa conoscere attraverso le immagini, come accade nel cinema.
Spessissimo senza saperlo si ascolta ottima musica contemporanea guardando film
come 2001- Odissea nello spazio di Stanley Kubrick in cui ci sono pezzi
di uno specialista del genere, György Ligeti.
Eppure i giovani ascoltano
per lo più rock, pop, metal e punk... Che cos’ha di diverso la musica
contemporanea?
Il rock o il pop sono
molto diversi da Schubert, non dalla musica contemporanea. Perché anche la musica contemporanea è diretta e pienissima di contrasti
drammatici. Si crede sia difficile da
capire, ma non è così: basta approcciarsi con mente aperta. Poi certo, anche
nella musica contemporanea, così come nel pop e nel rock, c’è del buono e del
cattivo: ma se non ti piace un pezzo, n on è detto che non te ne piacerà un
altro. Non si può decidere di non ascoltare più nulla, perché si è
rimasti delusi da un brano: sarebbe folle.
Nell’aprile 2011 è stata la
prima donna a dirigere un’opera alla Scala. Perché ci è voluto tanto?
Il tradizionalismo del mondo della musica
classica si rifà ancora al modello di società gerarchica del XIX secolo. Allora
anche il semplice musicista era un’attività esclusivamente maschile;
figuriamoci il direttore, che è in una posizione di leadership. Tuttora si
continua a vivere nel passato: per tutto il XX secolo le donne sono state
escluse dalle orchestre, e ancora oggi sono molto poche (nei Wiener
Philharmoniker sono solo tre). In questo senso il problema è solo la punta
dell’iceberg: innanzitutto bisogna che le donne entrino come strumentiste in
orchestra, solo allora non desteranno scalpore delle direttrici. Una donna non
guiderà mai un’istituzione, se prima non ci sono donne anche nei livelli
sottostanti. Lentamente le cose stanno cambiando, ma ci vorrà del tempo.
Non l’ha mai spaventata fare
un mestiere che rompeva dei tabù?
No, perché io sono lì nel ruolo di
direttrice per far funzionare qualcosa. Se sono capace e competente, tutto il
resto è secondario. Anche il fatto che sono una donna. Deve essere chiaro
l’ordine delle cose: prima viene la musica, poi i compositori e solo alla fine
vengo io.
La sua esperienza faciliterà
l’entrata delle donne nel mondo della direzione d’orchestra?
Sì, è molto diverso se nessuno apre la
strada. Ci sono molte persone che fanno da più tempo quello che faccio io, cioè
rompere tabù. Quando vado in un’orchestra dove non c’è mai stata una donna
prima, cambio qualcosa: ma quando una cosa accade, è accaduta. E tutto è più
facile.
Alla Scala quest'anno è stata
legata ad un importante programma sinfonico...
Si è trattato di una prima assoluta, cioè
un pezzo di Stefano Gervasoni scritto su misura per il violoncellista Francesco
Dillon. È un tipico dialogo tra solo e orchestra, ma anche un’occasione
importante visto che è stata una prima di un compositore italiano e per di più
alla Scala! È poi seguito un brano di Luciano Berio, un grande della musica
contemporanea italiana del XX secolo, basato su una partitura del compositore
settecentesco (anche lui violoncellista) Luigi Boccherini. Infine un concerto
di Béla Bartók, un personaggio che amo molto perché la sua musica arriva in
profondità e mi tocca da vicino.
Scusi, ma Stefano Gervasoni
(nato a Bergamo nel 1962) è un compositore vivente. Come si regola con
l’autore?
In effetti è un fatto che suona abbastanza
strano, ma discutere con i compositori è una delle cose che più mi piace della
musica contemporanea! Funziona così: prendo la partitura e la studio da sola.
Poi però ci incontriamo, la discutiamo e confrontiamo le nostre idee in
proposito. Io ho spesso domande su questioni pratiche a cui cerchiamo di
trovare soluzioni subito, visto che anche l’autore è presente alle prove.
Quando dirige si definirebbe
una “donna coi pantaloni”?
Ma sì, perché no? Quando dirigo, devo
essere forte, indipendente e prendere decisioni importanti. Direi proprio di
sì. Anche perché io metto proprio i pantaloni durante i concerti, visto che
indossare un vestito sarebbe una contraddizione rispetto a quello che sto facendo.
È come se in gonnella volessi sembrare solo il più bella possibile; io invece
mentre dirigo voglio proprio dimenticarmelo.
Ma mi dica, perché affascina
tanto i suoi musicisti?
Non so, sarà che anche se faccio il mio
lavoro molto bene, lo faccio sempre per la musica. A volte si trovano direttori
che ingigantiscono il loro ego a dismisura al sentirsi chiamare “Maestro...”.
Io credo che un direttore abbia tra le mani molte chiavi che deve saper gestire
solo nella funzione giusta. Personalmente ho un profondo amore per la musica
che mi dà energia. I musicisti partecipano al mio entusiasmo e così si crea
sintonia. Ecco, il segreto.<