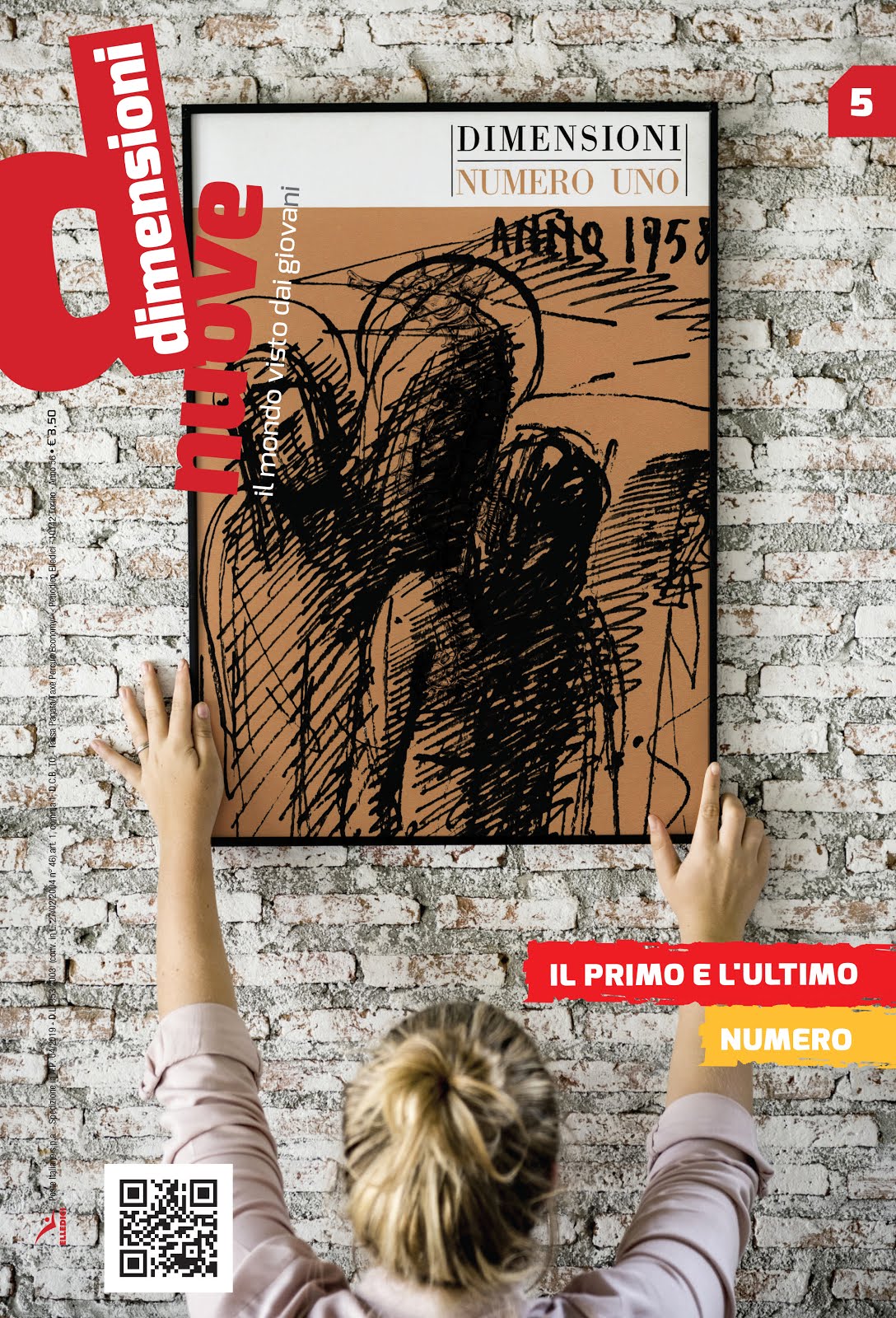Sapiens e i suoi bisnonni
di Giovanni Godio disegni di Sandro Zack Sapiens e i suoi bisnonni L’homo sapiens viene da una lunga storia per ora solo vagam...
https://www.dimensioni.org/2015/01/sapiens-e-i-suoi-bisnonni.html
di Giovanni Godio
disegni di Sandro Zack
e i
suoi bisnonni
L’homo sapiens viene da una
lunga storia
per ora solo vagamente
ricostruita.
Eppure tutto riporta ad un unico
punto da cui tutto ha avuto inizio.
La
ricerca scientifica degli ultimi decenni ha portato a scoperte sorprendenti su
ciò che viene chiamata “alba dell’uomo”,
mentre quasi non passa settimana senza che sui media rimbalzino notizie più o meno di origine controllata: «Il primo messaggio dei neandertaliani», «Come siamo diventati umani», «La lingua ancestrale di 15 mila
anni fa», «Così cambia l’albero genealogico dell’uomo», «Una madre per clonare l’uomo di
Neandertal» e via titolando... Frasi che lasciano
intuire come le teorie circa l’origine e lo sviluppo del genere umano restano ancora, per moltissimi
aspetti, avvolte in un grande mistero.
Quattro storie di vita
Fossili, oggetti e reperti, Dna e tracce sul terreno hanno
permesso di ricostruire
vicende (quasi)
senza tempo, all’alba dell’umanità: storie di vita e di morte, di caccia e
di passi, di bivacchi e migrazioni. Ecco quattro storie in cui riecheggia la stessa domanda: da dove veniamo
veramente?
 |
| ricostruzione del "Ragazzo del Turkana" vissuto 1,6 milioni di anni fa. |
Cammina, ragazzo del Turkana!
I pensieri, i sogni che gli attraversavano la mente non
li conosceremo mai. Aveva un fisico slanciato, anche se
il suo volto non era proprio da modello. Ossa leggere incredibilmente simili
alle nostre, alto più di un metro
e mezzo, da adulto avrebbe potuto raggiungere e superare il metro e 80. Viveva
sul lago Turkana, in Kenya, nella
Great Rift Valley. Il suo scheletro è stato scoperto nel 1984 (uno di quei
ritrovamenti che fanno la fortuna di un ricercatore, anzi, in questo caso, di
tre ricercatori), emergendo da un abisso temporale di 1,6 milioni di anni fa. Lo hanno
battezzato il “ragazzo del Turkana” e appartiene al genere Homo, Homo ergaster per la precisione.
Quando morì era un po’ come un adolescente. Lui e i suoi coetanei erano cresciuti più lentamente dei
predecessori, oggi diremmo in un’infanzia e in un’adolescenza “protratta”. Ma
allora, in quella “nuova” lentezza covavano progressi spettacolari per l’umanità. Il ragazzo del Turkana e la sua gente, un popolo di camminatori e di
migranti, vivevano in gruppi forse di una trentina di persone, avevano una
dieta onnivora di carne, frutti, erbe. Lavoravano già la pietra (anche se non erano stati i primi) e forse già combattevano la paura della notte attorno a un fuoco.
 |
| Le più antiche orme conosciute di individui del genere "Homo". |
Tracce di paura
Italia, un giorno di 300-400 mila anni fa. Il vulcano di
Roccamonfina, in quella che è oggi la Campania , è in piena eruzione. Gli animali cercano disperatamente una via di fuga giù per la montagna, pestando fanghiglia e cenere fresca. Ma fra loro ci
sono anche tre esseri umani: tre giovani, e comunque non di alta statura.
Corrono spaventati a zigzag, scivolano, in alcuni punti cercano appoggio
mettendo le mani sul terreno. In tutto lasciano 56 impronte che rimarranno,
pietrificate, a ricordare per sempre quel giorno di paura. Gli abitanti del
posto oggi le chiamano le “ciampate del diavolo”, ci hanno ricamato sopra
bizzarre leggende. Però sono forse le più antiche orme conosciute di una camminata di
individui del genere Homo. In questo caso, forse dell’Homo heidelbergensis. Anche questa forma
umana sarebbe partita dall’Africa. Circa 400 mila anni fa i parenti heidelbergenses dei fuggiaschi di
Roccamonfina costruivano le prime capanne nel sito francese di Terra Amata, nel nizzardo: piccole, minimali strutture
ellittiche di rami intrecciati. «Al loro interno gli archeologi hanno saputo
ricostruire le tracce di un’elaborata vita sociale
– annotano il genetista Luigi L. Cavalli Sforza e il filosofo della scienza
Telmo Pievani –: si riunivano attorno a un focolare per macellare gli animali,
forse per lavorarne le pelli e certamente per condividere forme di vita comunitaria».
Neandertal, nostro “alter ego”?
Questa volta la scena si fa un poco...
ipotetica. Al Museo Neanderthal di Krapina, in Croazia, hanno provato a realizzare il modello di una
giovane Neandertal che si specchia nell’acqua. Un omaggio all’eterna vanità femminile? Ci può stare. Però quest’immagine è soprattutto un simbolo di
autocoscienza e di mistero.
I Neandertal (così chiamati dalla valle tedesca di Neander), per decine di migliaia di anni
coabitarono con Homo
sapiens nel Vicino Oriente e in Europa. Nomadi e
cacciatori come i sapiens, si trovavano a loro agio anche nei climi freddi. Avevano forse un
linguaggio limitato ma una cultura
piuttosto evoluta (la cura di malati
e vecchi, la produzione di monili e forse di strumenti musicali). Però alla fine scomparvero, lasciando campo libero ai soli sapiens e a tanti
interrogativi: per qualcuno sono il nostro alter ego evoluzionistico, se
non addirittura un’altra specie, cioè un’umanità... “diversamente umana”. Ma è davvero così?
Su un letto d’ocra rossa
Era un giovane sui 15 anni, robusto e, per l’epoca,
di alta statura, sul metro e 70. È morto per un trauma
violento, forse un incidente di caccia. Nel paleolitico, 23-24 mila anni fa, lo hanno sepolto
in faccia al mare nella grotta delle
Arene Candide a Finale, in Liguria, dove è stato ritrovato nel 1942. Di sicuro non era un “principe” in senso
moderno, come lo hanno chiamato, ma doveva essere un giovane di rango «forse uno dei più abili cacciatori
del suo gruppo», azzardano al Museo archeologico ligure di Genova Pegli, che oggi ne
ospita i resti. Testimonia il suo status l’eccezionale corredo che lo ha
accompagnato nell’ultimo viaggio: il principe delle Arene Candide è stato deposto su un letto di ocra rossa con una cuffia di conchiglie, ciondoli e bracciali di conchiglie e d’avorio di mammut, ma anche con una lunga, preziosa lama in selce e quattro “pale” di
corno d’alce decorate e forate. Per Sforza e
Pievani, quella delle Arene Candide è «una delle più commoventi espressioni dell’umanità» di Homo sapiens.
Perché sì,
ormai in Liguria c’eravamo noi.
Condominio
Europa
Segni particolari: faccia piatta, gambe
lunghe, fronte alta. Ma anche una voglia incontenibile di esplorare e la
bizzarria di una lunga infanzia. Nome: Homo sapiens. Cioè noi, gli uomini e le donne che oggi vivono sulla terra. Veniamo da una
lunga storia, da tanti misteri. Ma, a quanto pare, da un luogo solo, l’Africa
centro-orientale.
I ritrovamenti
archeologici più arcaici di Homo sapiens provengono dalla valle del fiume Omo, in Etiopia: risalgono a 195 mila
anni fa, un arco di tempo che abbraccia ottomila generazioni. Relativamente
presto, forse già 100 mila anni fa, dall’Africa centro-orientale gruppi di nostri
progenitori, cacciatori e raccoglitori di frutti selvatici, varcarono la soglia
dell’Asia.
Come affermano Sforza e Pievani, fin
dalle origini africane «ciò che ci distingueva era un’anatomia slanciata, la faccia piatta, la
fronte alta, un’infanzia prolungata, una buona tecnologia di lavorazione della
pietra, una promettente organizzazione sociale e certamente una spiccata
attitudine alla dispersione in altri territori». Però, forse il nostro maggior “segreto” era una lunga infanzia, quel tempo che ci
permette di crescere, fantasticare, vedere e imparare sotto la protezione degli
adulti, «perché ha influito sulle capacità di apprendimento,
sull’organizzazione sociale e sul linguaggio».
 E 67 mila anni fa, l’Homo sapiens è già in Cina. Settemila anni dopo lascia nel Vicino Oriente sepolture intenzionali e conchiglie
perforate. E 50-45 mila anni fa si affaccia in Europa, dando origine a una
popolazione molto avanzata, quella che sarà battezzata di Cro-Magnon. Parleranno per i sapiens, fra l’altro, il “realismo
magico” delle decorazioni delle grotte di Chauvet, Lascaux, Altamira (forse i primi “santuari” dell’umanità), piccole sculture (frutto di capacità nuove ma anche di
tempo “libero” a disposizione!), strumenti musicali in osso, utensili di pietra e legno, la lavorazione di materiali col fuoco. Poi, nell’età della “pietra nuova” (il neolitico) arriveranno l’allevamento di animali e i campi coltivati. Le prime
città nel Vicino Oriente. Quindi la fusione dei metalli, l’invenzione della
ruota, della scrittura...
E 67 mila anni fa, l’Homo sapiens è già in Cina. Settemila anni dopo lascia nel Vicino Oriente sepolture intenzionali e conchiglie
perforate. E 50-45 mila anni fa si affaccia in Europa, dando origine a una
popolazione molto avanzata, quella che sarà battezzata di Cro-Magnon. Parleranno per i sapiens, fra l’altro, il “realismo
magico” delle decorazioni delle grotte di Chauvet, Lascaux, Altamira (forse i primi “santuari” dell’umanità), piccole sculture (frutto di capacità nuove ma anche di
tempo “libero” a disposizione!), strumenti musicali in osso, utensili di pietra e legno, la lavorazione di materiali col fuoco. Poi, nell’età della “pietra nuova” (il neolitico) arriveranno l’allevamento di animali e i campi coltivati. Le prime
città nel Vicino Oriente. Quindi la fusione dei metalli, l’invenzione della
ruota, della scrittura...
Ma non siamo stati i primi
E tuttavia non siamo stati noi i primi
europei e i primi asiatici. Quando i primi sapiens arrivarono in
Eurasia vi abitavano già altri gruppi umani:
il più famoso è quello dei Neandertal, così chiamati dalla valle tedesca di Neander. E anche Homo sapiens non nasce dal
nulla, perché proviene da un lungo (e diciamolo, ancora incerto) percorso evolutivo.
Ancora una volta, probabilmente, bisogna partire dall’Africa orientale, vera culla dell’umanità. I primi fossili
del genere Homo sono stati ritrovati fra Tanzania, Etiopia, Kenya e Malawi ed emergono
da un “pozzo temporale” che dà le vertigini, 2-2,5
milioni di anni fa: si parla di Homo habilis-rudolfensis. L’antropologo
Fiorenzo Facchini sottolinea come queste popolazioni fossero già in grado di fabbricare utensili di pietra (e, forse, di esprimere forme
di linguaggio).
Poi, per la prima
volta nella storia del mondo, gruppi di umani lasciarono l’Africa. Il più antico insediamento conosciuto fuori dal
continente è
quello di Dmanissi, in Georgia (1,8-1,7 milioni di anni fa). Le
tracce più
arcaiche dell’uso del fuoco risalgono a 1,5 milioni di anni fa. In Europa i
primi Homo entrano 300 mila anni dopo. I siti archeologici
più antichi in Europa centrale e occidentale si
trovano molto a Ovest, in Spagna, mentre le tracce dei “primi italiani”
risalgono a 800-700 mila anni fa e sono state scoperte a Monte Poggiolo (Forlì) e a Isernia la Pineta.
Ed ecco che, a partire da 150-100 mila anni fa, dal Medio Oriente alla Spagna e alla Siberia si afferma il nostro «alter ego»: lui, il Neandertal, erede come noi
delle ondate migratorie dall’Africa. Era robusto, più tozzo del sapiens, con un caratteristico “testone” sviluppato in orizzontale. Parlava
forse con un linguaggio nasale un po’ limitato (pare senza le vocali i, a, u e le consonanti g e k) e però si trovava a proprio agio nel clima dell’emisfero Nord del mondo, allora
ben più rigido di oggi.
Ma non è tutto. I Neandertal hanno lasciato
sepolture che rivelano una certa complessità sociale e un “mondo interiore”. A quanto pare
curavano i malati e i vecchi (le ossa di un individuo maturo ritrovate in una
sepoltura di Shanidar, in Irak, sono state curate dopo lesioni e fratture),
cospargevano i defunti di fiori e di semi. Ma ci sono anche le conchiglie
dipinte trovate a Cueva de los Aviones e Cueva Anton, in Spagna, e il femore d’orso
di Divje Babe, in Slovenia, bucato con fori regolari: forse un frammento del più antico flauto mai scoperto.
Di sicuro la capacità di concepire ed esprimere simboli e di costruire oggetti che non servono
a “nulla”, cioè di nessuna utilità materiale, «non nasce con Homo
sapiens», ha sintetizzato ancora Fiorenzo Facchini.
Desaparecidos
nel paleolitico
Nomadi e cacciatori come i sapiens, i Neandertal vivevano in piccoli
gruppi. E per decine di migliaia di anni coabitarono nei medesimi territori in
cui Homo sapiens si stava spargendo,
dal Vicino Oriente all’Europa e all’Asia, a volte alternandosi negli stessi
rifugi, con la medesima cultura. È probabile che vi
siano stati degli “incontri
ravvicinati” fra le due
popolazioni, anche se allora nel Vecchio mondo la densità umana era bassissima. Ma a partire da 29 mila anni fa dei Neandertal non si trova più traccia. Scomparvero. Perché? È uno dei grandi misteri della preistoria.
Piuttosto, le indagini di biologia
molecolare che negli ultimi anni si sono aggiunte allo studio dei fossili,
hanno infittito il mistero sull’identikit di Homo neanderthalensis. Secondo ricerche
pubblicate a partire dal 1997 dall’Istituto “Max Planck” di Lipsia, dal
confronto fra il Dna del Neandertal e il nostro (pure identici al 99,84%) emergerebbe che il primo non apparteneva alla nostra specie, cioè non avrebbe potuto incrociarsi con Homo sapiens generando figli
fecondi. Però studi più recenti dello
stesso istituto hanno rivelato che almeno i sapiens emigrati in Eurasia
potrebbero essersi incrociati con i Neandertal: cosa quasi impossibile, in natura, fra individui di specie diverse.
Secondo alcuni studiosi, un indizio di
questa ibridazione si trova in una sepoltura di
Lagar Velho, in Portogallo, che
per 24-25 mila anni ha custodito il sonno di un bambino sapiens dalle fattezze un
po’ “robuste”, simili a quelle di un Neandertal. La mostra “Homo
sapiens. La grande storia della diversità umana”, allestita
nel 2013 a
Novara, ha proposto una ricostruzione di questa sepoltura. Lui, il bimbo,
capelli corti e chiari, dorme raggomitolato, coperto di pelli e con un bastone
accanto: piccolo fratello e antico testimone dell’unica umanità.
Professore, aiuto! Qui c’è una novità alla settimana: e
il meeting dei
paleoantropologi di Tautavel 2014 che mette in discussione l’esistenza dell’homo heidelbergensis. E quel misterioso
1-3% di Dna neandertaliano che noi, sapiens d’Europa e d’Asia,
abbiamo ereditato dai Neandertal, a dimostrare che in Eurasia qualche mescolanza fra noi e loro ci fu
(Science, febbraio 2014). E il nuovo “ramo denisoviano” dell’albero genealogico
dell’umanità (Max Planck Institute 2013)... Per non smarrirci in un labirinto di ricerche, teorie e opinioni, abbiamo cercato (e trovato) la
gentilezza e la pazienza di Fiorenzo Facchini.
Bolognese, sacerdote e antropologo (ha insegnato Antropologia alla Statale di
Bologna), Facchini ha fatto ricerca in Asia centrale ed è il collaboratore di riferimento del quotidiano Avvenire sul tema delle origini umane.
Professor
Facchini, un suo articolo uscito a luglio si intitola “Un uomo solo al comando”.
Ma quali sono, in sintesi, le ultime novità sulle nostre origini?
Ci sono evidenze fossili che depongono
per somiglianze fra reperti lontani nel tempo e nell’area geografica. Anche i
recenti studi compiuti sui fossili di Dmanissi, in Georgia, che risalgono a
circa 1,8 milioni di anni fa, mettono in evidenza somiglianze con Homo habilis-rudolfensis di due milioni di anni fa e con Homo erectus (che è posteriore), suggerendo un unico ceppo originario nell’evoluzione dell’uomo.
Un
tempo si discuteva di “monogenismo” e “poligenismo”: l’umanità è sorta in un unico luogo o in luoghi
diversi della terra? Ma sono due aggettivi che non abbiamo più ritrovato lavorando per questo dossier:
letteralmente spariti. Come mai?
 In realtà bisogna vedere che
cosa si intende con questi termini. Monogenismo di per sé rimanda le origini a un’unica coppia, un evento difficile da inquadrare
in un quadro evolutivo che dovrebbe interessare una popolazione, anche se in
assoluto non si può escludere nulla.
Scientificamente, per l’evoluzione umana si preferisce parlare di “monofiletismo”,
di un unico ceppo. Il “polifiletismo”, come derivazione da più ceppi, non è suffragato da
evidenze scientifiche.
In realtà bisogna vedere che
cosa si intende con questi termini. Monogenismo di per sé rimanda le origini a un’unica coppia, un evento difficile da inquadrare
in un quadro evolutivo che dovrebbe interessare una popolazione, anche se in
assoluto non si può escludere nulla.
Scientificamente, per l’evoluzione umana si preferisce parlare di “monofiletismo”,
di un unico ceppo. Il “polifiletismo”, come derivazione da più ceppi, non è suffragato da
evidenze scientifiche.
Che
discendiamo dalle scimmie antropomorfe come lo scimpanzé oggi non lo sostiene più nessuno. Piuttosto si dice che con loro
abbiamo una parentela collaterale. Che cosa vuol dire?
Significa che sia le antropomorfe attuali
sia l’uomo derivano da un ceppo comune vissuto 7-8 milioni di anni fa. Dunque è una parentela molto lontana geneticamente: ci separano diversi milioni
di anni, nei quali sono avvenuti grandi cambiamenti.
Per
lei, quando si parla del genere Homo (habilis-rudolfensis, ergaster, erectus, heidelbergensis, neanderthalensis e infine sapiens) non si può fare immediatamente un’identificazione
con l’umanità in senso filosofico o religioso. Ma
allora in che stadio siamo diventati... veramente uomini? Con Homo sapiens o prima?
Nessuno può rispondere con certezza. La comparsa dell’uomo in quanto essere
intelligente deve essere stata puntuale, nel senso che ominidi non ancora
umani, sono stati arricchiti della dimensione spirituale. È il “salto ontologico” di cui parlava papa Giovanni Paolo II. Possiamo
ipotizzarlo in base alla documentazione del comportamento, quando cioè vi sono segni che indicano un’intelligenza astrattiva, un’attività spirituale. Molti paleoantropologi, e anch’io con loro, la riconoscono
già negli strumenti fabbricati da Homo habilis 2-2,5 milioni di
anni fa. Venendo più avanti nel tempo la
documentazione si fa più ricca e
significativa.
Spostiamoci
a periodi più recenti. Ancora nell’ultima edizione del libro Chi siamo?, di fine 2013, il
genetista Cavalli Sforza afferma che Homo sapiens condivise per un certo
periodo di tempo l’Eurasia con almeno altre tre “specie” umane: oltre ai
Neandertal, il piccolo “uomo di Flores” indonesiano e l’“uomo di Denisova”, che
visse sugli Altai, in Siberia.
Gli
stessi orientamenti si trovano nei saggi che Cavalli Sforza ha firmato con
Telmo Pievani. Queste “specie” diverse non ci pongono qualche problema come
credenti in Dio e nei suoi progetti per l’umanità, un’unica umanità?
Occorre cautela nell’individuare
le specie dell’umanità fossile. Alcuni amano vedere tante specie, ma è una posizione assai discutibile, perché molti autori
ritengono che si tratti di forme diverse che si sono succedute nel tempo.
La
stessa cultura, che caratterizza l’uomo, è un fattore di
comunicazione tra i gruppi umani, e può impedire l’isolamento
genetico necessario per la formazione di nuove specie. In alcuni casi si hanno
evidenze, nel Dna di uomini fossili, di mescolanze tra popolazioni ritenute da
alcuni come specie diverse, per esempio fra Neandertaliani e forme moderne di sapiens. Comunque non vedo
in questo dei problemi per la fede!
Piuttosto,
lei ha scritto di vedere negli scenari “multi-specie” qualche pregiudizio.
 Mi chiedo se questa tendenza a
riconoscere più specie nella stessa epoca non possa riflettere un atteggiamento ideologico.
Si accentuano le differenze per attenuare la specificità dell’uomo sul piano culturale e l’unicità delle origini
umane. E questo per offrire qualche appiglio per negare l’identità dell’essere umano
nella sua dimensione fisica e spirituale da quando è sulla terra, riducendolo a una scimmia evoluta.
Mi chiedo se questa tendenza a
riconoscere più specie nella stessa epoca non possa riflettere un atteggiamento ideologico.
Si accentuano le differenze per attenuare la specificità dell’uomo sul piano culturale e l’unicità delle origini
umane. E questo per offrire qualche appiglio per negare l’identità dell’essere umano
nella sua dimensione fisica e spirituale da quando è sulla terra, riducendolo a una scimmia evoluta.
La
fine, la sparizione dei Neandertal è un argomento di appeal anche mediatico.
Qualcuno ha anche parlato di “clonarli”... Ma davvero non si sa nulla di certo
sulla loro fine?
La questione è ancora aperta e sono state formulate tante ipotesi. Ogni tanto prende
corpo anche quella di un genocidio da parte dell’umanità moderna, però non se ne hanno le
prove. Anzi, come dicevo, in varie regioni vi sono indizi che convivessero
Neandertaliani e forme moderne, con la medesima cultura e che anche si
incrociassero.
L’insegnamento
della Chiesa sull’evoluzione dell’uomo: il punto d’arrivo è sempre il Messaggio di papa Wojtyla alla
Pontificia accademia delle scienze del 1996? Da un lato il “salto ontologico”,
dall’altro l’affermazione che la teoria dell’evoluzione non può più essere considerata come «mera ipotesi».
Sì, sono questi i due punti da tenere fermi. Il secondo, il carattere
scientifico della teoria dell’evoluzione, è un riconoscimento,
quasi una constatazione doverosa. Il primo è un’affermazione di
ordine filosofico-teologico, su cui la scienza in quanto tale ha poco da dire,
perché è un’affermazione che non la tocca. E lascia aperta la discussione su
quando è comparso l’uomo. <