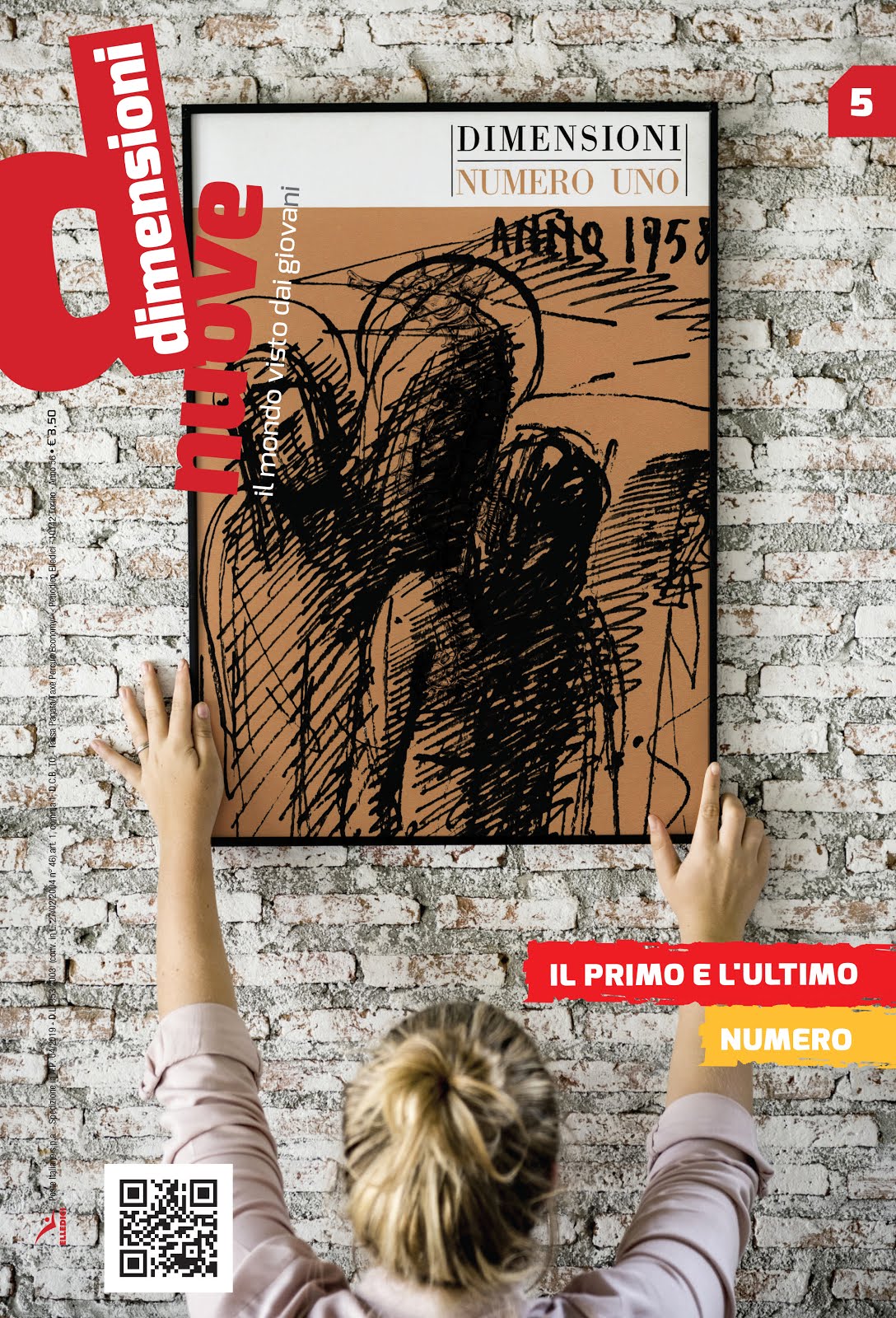Sembra vero! Intervista a Max Solomon
È il mago che ha curato gli effetti speciali del film “Gravity”. Max Solomon svela alcuni segreti delle sperimentazioni che hanno reso su...
https://www.dimensioni.org/2014/01/sembra-vero-intervista-max-solomon.html
Max Solomon svela alcuni segreti delle sperimentazioni
che hanno reso sullo schermo la “gravità zero” più realistica che mai.
La prima cosa da fare quando si va
al cinema per vedere Gravity di Alfonso Cuaròn (Usa 2013) è dotarsi di un massiccio quantitativo di “suspension of
disbelief”. Un tacito accordo tra pubblico e regista, citato da Giovanni
Bignami, direttore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, su La Stampa, nel
quale lo spettatore “fa finta di crederci” e accetta un racconto
cinematografico basato su condizioni fisiche palesemente impossibili.
Gravity è notevole non tanto per la storia
(sceneggiatura ridotta all’osso, praticamente assente) e nemmeno per il suo
valore scientifico (fondamentalmente inaffidabile) ma per l’utilizzo degli
effetti speciali, sotto la sapiente guida di Max Solomon, che rappresentano una
vera rivoluzione nel cinema.
Uscito il 3 ottobre in Italia,
Gravity è stato proiettato a Torino in
occasione del View Fest, che si è svolto presso la Multisala Cinema Massimo tra l’11 e il
13 ottobre. Il film ha riscosso un notevole successo di pubblico e qualche
appunto dalla critica dovuta al suo eccesso di fiction.
 Max Solomon, direttore dell’animazione
presso Framestore per questo film, ha parlato al pubblico il 15 di ottobre,
durante uno dei keynote programmati all’interno di View Conference, l’evento
conseguente al View Fest che consentiva di incontrare i tecnici che hanno
lavorato ai film proiettati durante la manifestazione. Solomon, che ha curato
la previsualizzazione e le riprese, è stato anche supervisore dell’animazione e animatore in
diversi film di Harry Potter e artista digitale ne Il cavaliere oscuro.
Max Solomon, direttore dell’animazione
presso Framestore per questo film, ha parlato al pubblico il 15 di ottobre,
durante uno dei keynote programmati all’interno di View Conference, l’evento
conseguente al View Fest che consentiva di incontrare i tecnici che hanno
lavorato ai film proiettati durante la manifestazione. Solomon, che ha curato
la previsualizzazione e le riprese, è stato anche supervisore dell’animazione e animatore in
diversi film di Harry Potter e artista digitale ne Il cavaliere oscuro.
Poca scienza, molta fantascienza
 Ma di cosa parla Gravity? La storia è molto semplice. Matt Kowalski (George Clooney) è il comandante di una missione di routine nell’orbita
terrestre a bordo di un piccolo shuttle, sul quale è imbarcata anche Ryan Stone (Sandra Bullock), medico per
la prima volta nello spazio.
Ma di cosa parla Gravity? La storia è molto semplice. Matt Kowalski (George Clooney) è il comandante di una missione di routine nell’orbita
terrestre a bordo di un piccolo shuttle, sul quale è imbarcata anche Ryan Stone (Sandra Bullock), medico per
la prima volta nello spazio.
Durante un’operazione di riparazione a un pannello
elettronico dello shuttle, una tempesta di detriti colpisce gli astronauti e il
mezzo, e Kowalski e Stone sono gli unici sopravvissuti. La naturalezza con la
quale vengono mostrati gli astronauti che galleggiano nel vuoto, esattamente
come gli oggetti che maneggiano, è talmente
dettagliata da non saltare nemmeno all’occhio. Come si suol dire: se una cosa
funziona bene non si nota.
 Le critiche più forti rivolte a
questo film riguardano la sua scarsa attendibilità scientifica. «Ci sono operazioni che durano ore – ha ribattuto Solomon
poco prima del suo intervento a View Conference – ma che abbiamo dovuto
velocizzare per farle durare pochi secondi e riuscire a inserirle nel film». Cinque anni di lavorazione per questo hyper realistic
space thriller, a partire dall’idea iniziale del regista Alfonso Cuaròn, hanno portato alla produzione di un gioiello della
tecnologia. «Il problema più grande – ha
raccontato Solomon – riguardava le luci, che dovevano essere molto definite e
di colore diverso a seconda della posizione dei personaggi nello spazio, se
rivolti verso il sole o verso la terra. Inoltre dovevano essere realistiche».
Le critiche più forti rivolte a
questo film riguardano la sua scarsa attendibilità scientifica. «Ci sono operazioni che durano ore – ha ribattuto Solomon
poco prima del suo intervento a View Conference – ma che abbiamo dovuto
velocizzare per farle durare pochi secondi e riuscire a inserirle nel film». Cinque anni di lavorazione per questo hyper realistic
space thriller, a partire dall’idea iniziale del regista Alfonso Cuaròn, hanno portato alla produzione di un gioiello della
tecnologia. «Il problema più grande – ha
raccontato Solomon – riguardava le luci, che dovevano essere molto definite e
di colore diverso a seconda della posizione dei personaggi nello spazio, se
rivolti verso il sole o verso la terra. Inoltre dovevano essere realistiche».
Un problema non indifferente se si pensa che l’ambientazione
è stata completamente costruita in computer grafica, ma
come ha mostrato Solomon durante la sua conferenza, non è possibile ricostruire completamente ogni movimento e
ogni colore poiché il risultato che
si otterrebbe non sarebbe fluido e attendibile.
Lo spazio in un cubo
 Ed ecco la trovata di Max Solomon, la Light Box: «Abbiamo costruito un cubo di tre metri per tre, all’interno
del quale ogni pannello era ricoperto di led, in totale ne abbiamo utilizzati 1
milione e 800 mila. Gli attori si muovevano all’interno di questa scatola che
utilizzavamo per ricreare l’esposizione dei loro visi alla luce, in base a ciò che ci serviva».
Ed ecco la trovata di Max Solomon, la Light Box: «Abbiamo costruito un cubo di tre metri per tre, all’interno
del quale ogni pannello era ricoperto di led, in totale ne abbiamo utilizzati 1
milione e 800 mila. Gli attori si muovevano all’interno di questa scatola che
utilizzavamo per ricreare l’esposizione dei loro visi alla luce, in base a ciò che ci serviva».
Certo, recitare all’interno di una scatola non deve
essere stato semplice. «In effetti – ha
ammesso Solomon – George Clooney e Sandra Bullock hanno avuto parecchie
difficoltà, dovute alla scomodità delle
attrezzature e dei luoghi utilizzati per le riprese. Più che altro perché non lo avevano
mai fatto prima».
Per ideare il procedimento che ha portato alla produzione
del film sono stati necessari diversi test, come i tentativi per riprendere i
movimenti degli attori in maniera tradizionale o le simulazioni al computer dei
movimenti da far fare agli oggetti che esplodono nello spazio.
La pellicola ha richiesto un lavoro immenso di post
produzione, un assemblaggio al computer delle diverse parti registrate
separatamente attraverso la macchina da presa. Come ha mostrato Solomon durante
la conferenza del 15 ottobre, Sandra Bullock e George Clooney hanno recitato su
strutture che simulavano il fluttuare nel vuoto dei corpi degli astronauti,
mentre l’obiettivo della cinepresa registrava esclusivamente le loro
espressioni facciali. La tuta spaziale, gli oggetti che si spostano nel vuoto,
i loro corpi e le stazioni orbitanti sono stati aggiunti in un secondo momento.
Ma ciò che colpisce di questo enorme
lavoro di ricostruzione è la lunghezza delle scene, con piani sequenza di
sbalorditiva fluidità. «Ogni ripresa lunga, mediamente, è composta da 11 mila fotogrammi, a
parte quella iniziale che ne conta 19 mila – ha aggiunto Solomon – ed è anche per questo che abbiamo
avuto molte difficoltà con le luci, che hanno richiesto un lavoro approfondito
da parte del direttore della fotografia. La Light Box è stata progettata insieme a lui».
Un laboratorio creativo
Ogni film è un laboratorio
creativo e produce invenzioni che trovano applicazione, a volte, in altre
pellicole o addirittura in contesti esterni al cinema. È il caso della steadycam, macchina da presa con un
supporto legato al corpo dell’operatore che consente la realizzazione di
riprese fluide e lunghe con uno sforzo sostenibile.
 Questa soluzione nacque verso la fine degli anni ’80, ma
fu messa a punto grazie a un film, Halloween, la notte delle streghe di John
Carpenter (1978), per trovare la propria consacrazione grazie a Stanley Kubrick
e al suo Shining (1980).
Questa soluzione nacque verso la fine degli anni ’80, ma
fu messa a punto grazie a un film, Halloween, la notte delle streghe di John
Carpenter (1978), per trovare la propria consacrazione grazie a Stanley Kubrick
e al suo Shining (1980).
Quindi non è escluso che la
Light Box creata da Max Solomon e dal suo team (ai suoi ordini ben 30
animatori) trovi applicazione nelle future produzioni cinematografiche. Una
piccola rivoluzione? «Gravity non ha
nulla di nuovo dal punto di vista della storia e del soggetto – commenta
Solomon – ma sicuramente può influenzare le
produzioni future sulla ricostruzione della realtà. Abbiamo
visionato ore e ore di filmati dei viaggi reali avvenuti nello spazio e ci
siamo basati su modelli esistenti di stazioni, shuttle e tute spaziali per
utilizzarli in questo film. Il regista è stato molto
scrupoloso».Il team ha cercato anche di “sperimentare sul campo” la
realtà a gravità zero, per quanto
possibile. L’occasione è stata fornita
dal cosiddetto Vomit Comet, un aereo in grado di volare verso l’alto a
grandissima velocità per poi scendere
in picchiata altrettanto velocemente, più volte durante lo
stesso volo.
I passeggeri, opportunamente assicurati, possono così sperimentare la gravità zero all’interno
del velivolo durante le discese. Indispensabile, quindi, un viaggio di questo
genere prima della fine della lavorazione.
 Quando ci si trova davanti a personaggi come Max
Solomon, ci si chiede spesso come si arrivi a svolgere professioni di questo
livello. «All’interno di un film – ha spiegato – ci sono
tantissime persone che provengono da percorsi molto diversi tra loro. Io sono
un animatore, ho fatto anche l’illustratore, ma in Gravity c’erano esperti di
computer grafica e programmatori. Ci sono diverse competenze che vengono messe
insieme». Non c’è un vero
percorso, solo lavoro, impegno, competenze e tanta, tantissima voglia di sperimentare
per cercare sempre l’effetto migliore.
Quando ci si trova davanti a personaggi come Max
Solomon, ci si chiede spesso come si arrivi a svolgere professioni di questo
livello. «All’interno di un film – ha spiegato – ci sono
tantissime persone che provengono da percorsi molto diversi tra loro. Io sono
un animatore, ho fatto anche l’illustratore, ma in Gravity c’erano esperti di
computer grafica e programmatori. Ci sono diverse competenze che vengono messe
insieme». Non c’è un vero
percorso, solo lavoro, impegno, competenze e tanta, tantissima voglia di sperimentare
per cercare sempre l’effetto migliore.