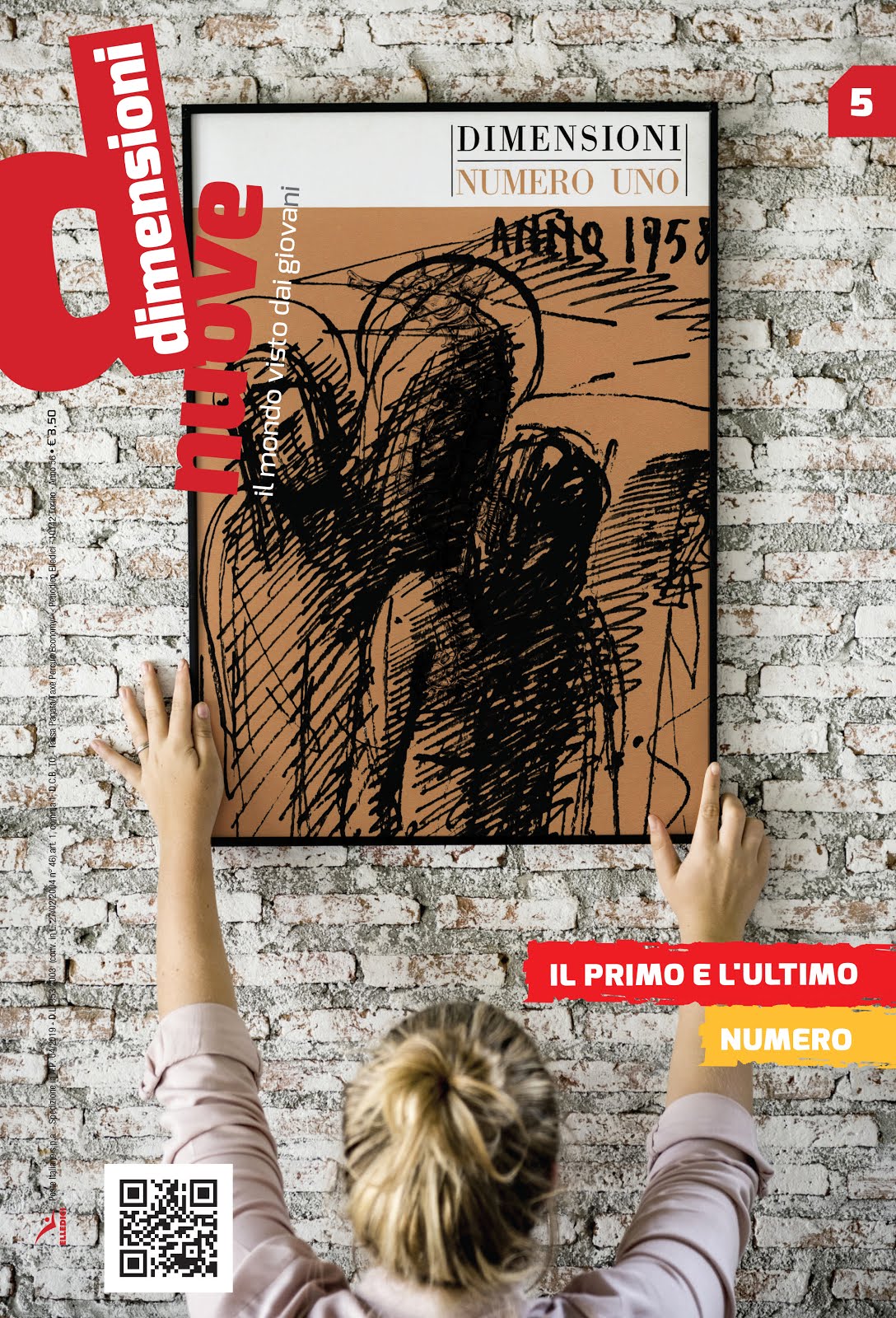Nutrire il pianeta, energia per la vita
di Carlo Mantovani Autorevoli personaggi a confronto Nutrire il pianeta, energia per la vita Expo Milano 2015 si confronta con i...
https://www.dimensioni.org/2015/02/nutrire-il-pianeta-energia-per-la-vita.html
di Carlo Mantovani
Autorevoli
personaggi a confronto
Nutrire il pianeta, energia per la vita
Expo Milano 2015 si confronta con il problema del
nutrimento dell’uomo e della Terra e si pone come momento di dialogo
tra i protagonisti della comunità internazionale
sulle principali sfide dell’umanità.
 Quando ho saputo che il tema dell’Expo di Milano era
“Nutrire il pianeta”, mi sono detto: data la vocazione alimentare, quale modo
migliore, per prepararsi all’evento, che parlare di cibo? Soprattutto perché ho
avuto l’occasione, nel corso degli ultimi mesi, di ascoltare personaggi
autorevoli come Michael Pollan, giornalista e scrittore statunitense
salito alla ribalta per le sue inchieste sul rapporto tra cibo, agricoltura e
salute; Hans Rudolf Herren, entomologo svizzero di fama internazionale e
pioniere dell’agricoltura sostenibile; e, last but not least, Cinzia
Scaffidi, direttore del Centro Studi di Slow Food e responsabile delle
relazioni internazionali dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e
Colorno.
Quando ho saputo che il tema dell’Expo di Milano era
“Nutrire il pianeta”, mi sono detto: data la vocazione alimentare, quale modo
migliore, per prepararsi all’evento, che parlare di cibo? Soprattutto perché ho
avuto l’occasione, nel corso degli ultimi mesi, di ascoltare personaggi
autorevoli come Michael Pollan, giornalista e scrittore statunitense
salito alla ribalta per le sue inchieste sul rapporto tra cibo, agricoltura e
salute; Hans Rudolf Herren, entomologo svizzero di fama internazionale e
pioniere dell’agricoltura sostenibile; e, last but not least, Cinzia
Scaffidi, direttore del Centro Studi di Slow Food e responsabile delle
relazioni internazionali dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e
Colorno.
Cucina casalinga
uguale a salute
Pollan,
ospite del Festival Letteratura di Mantova per presentare la sua nuova opera, Cotto,
ha chiarito subito l’importanza di imparare a cucinare: a suo parere la
chiave per salvare sia l’agricoltura, sia la nostra salute.
Solo
cucinando, infatti, possiamo impedire che l’industria alimentare decida quello
che finisce nel nostro piatto e interrompere il monopolio delle grandi aziende
agricole che soffocano quelle a conduzione familiare, tutrici della biodiversità.
Mettersi ai fornelli e trasformare le materie prime avrebbe effetti benefici
anche sulla nostra salute: perché, al di là dei grassi e degli zuccheri
presenti, il cibo cucinato da una persona sarà sempre più sano di quello, pieno
di chimica, prodotto dall’industria alimentare.
Chiariamo
subito un concetto, dice Pollan: il pullulare di cuochi nelle trasmissioni
televisive e gli stessi talent show culinari non spingono la gente a
cucinare di più. Anzi, la scoraggiano: l’idea sdoganata dal piccolo schermo,
infatti, è quella che cucinare sia una cosa difficile e costosa, riservata ai
professionisti. Siamo di fronte al cosiddetto paradosso culinario:
invece di accendere i fornelli e cucinare, preferiamo accendere la tv e
guardare cucinare gli altri.
Agricoltura
sostenibile
 Tra gli
ospiti del Festival Letteratura c’era anche Hans Rudolf Herren, paladino
dell’agricoltura sostenibile, cioè quella che non danneggia il pianeta, ma lo
rende più ricco e vivibile. L’agricoltura attuale, purtroppo, essendo al
servizio dell’industria alimentare, non ha nulla di sostenibile: spreca,
consuma e inquina. Anche a causa di falsi miti. Non è vero, ad esempio,
che occorra produrre più cibo. Di cibo ne produciamo fin troppo: se è vero che,
tra Stati Uniti ed Europa, il 40% degli alimenti finisce nella spazzatura.
Tra gli
ospiti del Festival Letteratura c’era anche Hans Rudolf Herren, paladino
dell’agricoltura sostenibile, cioè quella che non danneggia il pianeta, ma lo
rende più ricco e vivibile. L’agricoltura attuale, purtroppo, essendo al
servizio dell’industria alimentare, non ha nulla di sostenibile: spreca,
consuma e inquina. Anche a causa di falsi miti. Non è vero, ad esempio,
che occorra produrre più cibo. Di cibo ne produciamo fin troppo: se è vero che,
tra Stati Uniti ed Europa, il 40% degli alimenti finisce nella spazzatura.
Insomma:
non bisogna produrre di più, ma produrre meglio. La soluzione, assicura
Herren, esiste: basterebbe insegnare ai Paesi poveri a coltivare, in modo che
raggiungano l’autonomia alimentare. Una cosa che però le multinazionali del
cibo vogliono assolutamente impedire, perché minerebbe il loro perverso
controllo sul mercato globale. E ci riusciranno senz’altro, se continueremo a
permettergli di comprare i terreni liberi dei Paesi in via di sviluppo: come si
fa a produrre cibo, se non si hanno terreni da coltivare?
E lo
scandalo aumenta, se pensiamo che la terra buona acquistata dalle
multinazionali, in genere, non viene coltivata, ma destinata ad altri
scopi: come edificare o produrre energia. I pochi terreni destinati
all’agricoltura, poi, vengono maisificati, cioè destinati alla
produzione di cereali, una materia prima utilissima all’industria alimentare
(ci ricavano di tutto), ma che alla lunga danneggia la nostra salute e quella
del pianeta, impoverito dalla monocoltura.
 Ecco
perché l’Onu ha deciso di dedicare il 2014 alle family farm, le aziende
agricole a conduzione familiare: solo sostenendo chi pratica l’agricoltura biologica,
infatti, potremo avere terreni fertili e cibo sano. E per farlo, dobbiamo
cambiare le nostre abitudini di consumatori: disposti a investire mezzo
stipendio per uno smartphone, ma non ad aggiungere anche un solo euro per aver
alimenti genuini.
Ecco
perché l’Onu ha deciso di dedicare il 2014 alle family farm, le aziende
agricole a conduzione familiare: solo sostenendo chi pratica l’agricoltura biologica,
infatti, potremo avere terreni fertili e cibo sano. E per farlo, dobbiamo
cambiare le nostre abitudini di consumatori: disposti a investire mezzo
stipendio per uno smartphone, ma non ad aggiungere anche un solo euro per aver
alimenti genuini.
Un
nuovo vocabolario
alimentare
Cinzia Scaffidi l’ho incontrata a Ferrara, in occasione del Festival di Internazionale,
dove presentava il suo libro, Mangia come parli: com’è cambiato il
vocabolario del cibo. Quando discutiamo di un piatto, ricorda la
rappresentante di Slow Food, è fondamentale distinguere due concetti: se
diciamo mi piace/non mi piace, stiamo parlando di noi, se invece diciamo è
buono/non è buono, ci riferiamo al cibo. Oggi, però, i nostri gusti sono
talmente condizionati dai sapori standardizzati e globalizzati dell’industria
alimentare, che abbiamo confuso i due piani: e non è buono, in realtà,
significa non mi piace.
E non dobbiamo stupirci, perché nel settore alimentare la
confusione, ormai, regna sovrana. Come nella pubblicità: dove il presunto
mulino di Banderas, in realtà, è un frantoio per olive; e il formaggio, per sua
natura grasso, viene definito magro nella speranza di aumentare le
vendite.
A disorientare
il consumatore e a confondergli le idee contribuisce anche la legge che,
nell’uso delle parole, sembra aver divorziato dal buon senso: e così, dietro il
termine aromi naturali, si nascondono sostanze chimiche che riproducono
il loro sapore; i cosiddetti gelati artigianali sono semilavorati
industriali il cui unico elemento “artigianale” è l’aggiunta di acqua e latte;
e, per poter legalmente scrivere made in Italy su un barattolo di
macedonia, basta che la frutta, proveniente da chissà dove, sia stata
inscatolata nel nostro Paese.
A
completare il quadro, ci pensano le etichette: che dovrebbero descrivere
la storia e la geografia di un prodotto e invece sono quasi sempre lacunose e
incomprensibili. Insomma, un fenomeno piuttosto inquietante. Che noi, tuttavia,
possiamo bloccare ricorrendo all’unica ma potentissima arma a nostra
disposizione: l’educazione.
Educare al cibo i nostri ragazzi: sfruttando, ad esempio, le enormi potenzialità delle
mense scolastiche. Per consentire di riconoscere le materie prime e comprendere
come vengono utilizzate in cucina; per dare le informazioni necessarie a capire
l’importanza di salvare tesori gastronomici come il pomodoro San Marzano,
sempre meno coltivato perché non adatto alla produzione industriale; e
distinguere, finalmente, ciò che è buono, da ciò che non lo è. <